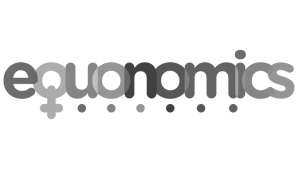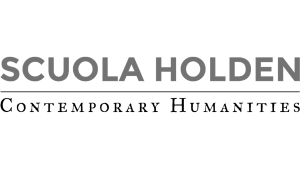C’è stato un giorno, un po’ di tempo fa, in cui mi stavo facendo una magnifica nuotata in piscina. C’era quest’acqua fantastica e c’ero io.
Nient’altro contava, solo quello sciabordio impercettibile del corpo che era lama, e tagliava la superficie in un modo esatto e bello.
Non so nuotare bene. Non so nuotare proprio, credo. Però mi piace farlo, galleggio, riemergo, ritorno. Sì, c’è tutta una concezione primordiale di come ti comporti in acqua che non è mai come ti comporti sulla terra perché gli orizzonti sono diversi e diverso è il tuo stare.
Galleggi, il più delle volte, senza chiederti perché.
Mi è tornata in mente quella nuotata, stamattina, all’indomani della mia partecipazione a IF! Italians Festival, dove, con Marina Cuollo e Eugenia Nicolosi, abbiamo provato a raccontare di come alcuni stigmi esistano e colpiscano alcune categorie di persone e, nello specifico, le persone con disabilità.
Di come ci sia tutta una narrazione infantilizzante che le relega a eterni soggetti passivi, però carini, di cui prendersi cura. Di come le persone disabili siano, in definitiva, sempre viste come intrinsecamente buone. Solo un po’ sfigate, ecco, e però possono insegnarci tante cose tra cui l’odiata resilienza, la più odiata empatia e l’odiatissimo coraggio.
Ora, non che per alcune persone disabili questo non sia vero. Ci saranno di certo persone disabili intrinsecamente buone, resilienti, coraggiose e empatiche. Ma, esattamente come ogni altra persona, questo non è vero a priori e non è vero sempre.
Categorizzare e imprigionare dentro narrative limitanti è dannatamente sbagliato, specialmente se per lavoro comunichi. Perché consegni là fuori un racconto distorto che finisce per cementarsi all’interno di immaginari condivisi. Da quegli immaginari possiamo poi pescare tutti e tutte, continuando a distorcere ulteriormente la realtà, continuando a non vedere l’acqua, lasciandoci galleggiare senza chiederci il perché.
Da qui, vorrei ripartire oggi.
Dal sentire l’acqua, vederla, capirla. Sento una enorme responsabilità in questo. Come persona privilegiata e come creativa, come una che ogni giorno fa un accurato check di tutto ciò che ancora non sa.
Quando parlo di discriminazione e quindi del suo contraltare che è il privilegio, la maggior parte delle risposte che ricevo hanno a che fare con un assunto: il privilegio riguarda la ricchezza, lo status, il colore della pelle, la provenienza, l’orientamento sessuale, il possedere un corpo abile. Più o meno tutto ciò che non siamo in grado di controllare, che ci succede, con cui nasciamo.
È indubbiamente tutto questo ma, soprattutto, il privilegio è un atteggiamento.
Riguarda il modo in cui vedi la realtà e comprendi (oppure non lo fai) le altre persone.
Riguarda le ipotesi che fai.
Riguarda i tuoi punti ciechi e come tratti chi è diverso da te.
Riguarda ciò a cui pensi di avere diritto e ciò che credi gli altri meritino.
Riguarda l’orizzonte attraverso cui filtri i problemi, le loro cause e le loro soluzioni.
Riguarda come pensi.
Riguarda come porti tutto questo all’interno del lavoro creativo. Di quali domande ti fai, di come sai farti da parte. Soprattutto, di come sai farti da parte.
Viviamo un mondo competitivo e spietato. Dove chi eccelle ha più o meno sempre le stesse caratteristiche e usa metafore come “la legge della giungla”. Prova ad ascoltare qualcunə che non ha mai dovuto combattere con la discriminazione: è un predatore, al suo apice, parla di ghepardi e gazzelle e guarda caso è sempre il ghepardo. La maggior parte di queste persone non saprebbe sopravvivere manco in campeggio senza una batteria per l’Iphone.
Ti viene voglia di portarcele davvero, nella giungla. E lasciarle lì.
Il fatto è che per giustificarsi si appropriano del dibattito. Ci entrano con la forza, dicono che sono al servizio degli altri. Lo dicono, ma non è così. Vogliono rendere il mondo un posto migliore, ma solo se questo coincide con un miglior luogo per loro stessə. Usano questa storia per proteggersi, come un’aureola santificatrice che possa metterle al riparo dalle critiche e, al contempo, consolidare il loro mito. Se fosse solo una questione di ego sarebbe il meno ma il punto è che spostano il traguardo di un futuro giusto sempre un po’ più in là.
Farsi da parte non è contemplato. Leggere la complessità e scandagliarla nemmeno. Così, all’interno dei lavori creativi tutto si appiattisce, si assottiglia, si riduce. Il punto di vista di chi detiene il potere rimane l’unico in gara perché lo scettro è più importante del messaggio anche se di quel messaggio dovrebbe beneficiarne chi lo scettro non ce l’ha.
È così ricorsiva questa dinamica, l’abbiamo vista succedere più di quanto vogliamo ricordare. Io, per esempio, sono stanca di ricordare le infinite volte in cui questa violenza accade.
Perché mi distrae.
Voglio stare nell’acqua, sentirla, spostare il baricentro e farmi da parte, voglio toccare gli orizzonti e modificarli, chiedendomi, se necessario, una volta in più perché.
Il cambiamento è così: si infiltra, fluisce, arriva. Può farlo come goccia o come onda. Di certo, invece di innalzare muri è meglio capire come costruire ponti.